Voce profetica e indifferenza: Zwingli e il futuro della chiesa
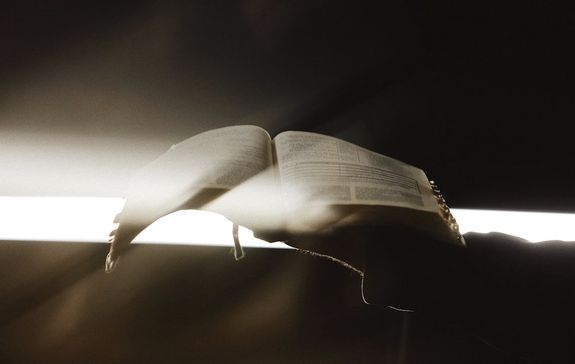
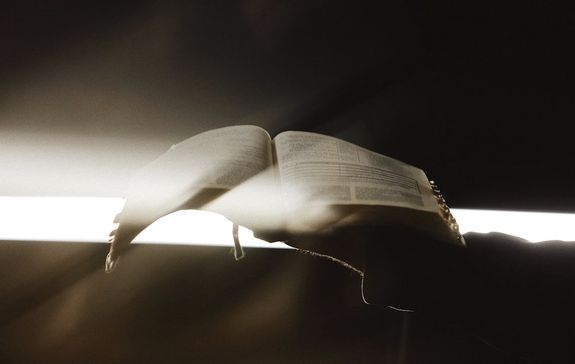
Pubblichiamo l’integralità dell’intervento di Bruce Gordon, docente di teologia e storia della Riforma alla Yale University (USA), pronunciato in occasione del recente simposio “Il futuro della chiesa riformata in Svizzera”, svoltosi all’Università di Zurigo, 19-21 ottobre 2025.

Nel mio intervento odierno vorrei riunire due parti della mia vita che sono profondamente connesse: i miei anni di ricerca e di scrittura sulla Riforma svizzera e la mia amicizia in Svizzera con persone che non si identificano nella chiesa e per cui la chiesa è di scarso o di nessun rilievo nella loro vita. A partire da questa combinazione voglio proporre alcune riflessioni intenzionalmente provocatorie, poiché, come ha sottolineato questo simposio, siamo in un momento di crisi. Vorrei suggerire che questa crisi non tocca soltanto la chiesa, ma anche le persone con cui ho parlato. Vorrei imperniare la mia esposizione su un termine che è emerso più volte nelle conversazioni e che ha un ruolo importante nella tradizione cristiana: indifferenza.
Le chiese hanno difficoltà a trovare il proprio posto in società profondamente secolarizzate in quasi ogni aspetto della vita. Allo stesso tempo molti giovani sono disincantati, persino cinici nei confronti della politica, delle istituzioni e della cultura pervasiva del materialismo, del consumismo e della mercificazione che definisce la nostra epoca.
Sono profondamente grato ai miei amici e studenti che si sono presi il tempo di condividere con me i loro punti di vista. La loro prima risposta è stata spesso: “Non so nulla al riguardo”, seguita dalla sorpresa che un argomento del genere possa essere oggetto di una conferenza. Erano incuriositi, a volte sbalorditi, e i loro commenti, sebbene familiari, erano rivelatori. Molti davano per scontata la scarsa rilevanza della chiesa nel futuro. Nella maggior parte dei casi ignoravano le questioni che stiamo discutendo nel corso di questa settimana semplicemente perché non ci pensano. Quando parlano di amici cristiani li descrivono come individui che hanno fatto una scelta di vita personale che ne soddisfa le necessità, qualcosa che loro stessi non si sentono in dovere di condividere.
Molti, in particolare in Svizzera, sono disgustati da ciò che sentono riguardo alle chiese americane, che percepiscono come reazionarie, conservatrici, moraliste e ostili all’omosessualità, certamente in contrasto con gran parte di ciò che considerano come una vita normale. Gli scandali nella chiesa cattolica sono spesso citati come emblematici dell’ipocrisia e della corruzione. I discorsi vaghi sull’amore di Dio suscitano indifferenza: “Suona bene, ma sono a posto così”. La giustizia sociale, l’ambiente e la pace sono percepiti come preoccupazioni positive, ma che non richiedono alcun legame con la religione organizzata. Un amico svizzero, un pianista concertista, mi ha raccontato di un volo da San Francisco all’Europa seduto accanto a una donna che cercava di convertirlo parlandogli dell’inferno. La sua risposta: “Avrei preferito andare all’inferno piuttosto che ascoltarla”.
I miei amici sono per la maggior parte colti e riconoscono il ruolo del cristianesimo nel plasmare la cultura. Lo considerano parte della loro storia, persino della loro identità, ma come una cosa distante, custodita in edifici e racconti. A Ginevra sanno menzionare Calvino; a Zurigo Zwingli, forse. Ma pochi sanno dire altro della Riforma. Ironizzano sull’etica protestante del lavoro o sul protestantesimo come fonte della loro frugalità o dei loro sensi di colpa. Le chiese sono apprezzate per la loro bellezza, la loro arte e la loro architettura e sono frequentate principalmente per concerti o perché cantano in un coro o suonano in un’orchestra.
Il linguaggio teologico è loro completamente estraneo. Pochi sanno spiegare la differenza tra cattolicesimo e protestantesimo al di là dei principi generali o delle tradizioni familiari. Sono quasi tutti battezzati, ma considerano quel battesimo semplicemente una tradizione di famiglia. Il battesimo e la confermazione sono riti sociali e non spirituali. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stato che nonostante l’elevato grado di istruzione avevano difficoltà a parlare persino dei più elementari concetti teologici. Un caro amico di Ginevra ha letto la mia biografia di Calvino e mi ha detto di averla apprezzata molto, ma mi ha anche confessato di aver trovato “le parti religiose” di difficile comprensione. Ha studiato fisica al Politecnico federale di Zurigo, parla cinque lingue e dirige una start up medica a Zurigo. Una volta abbiamo parlato del facile accesso dei giovani alla pornografia; ha fatto spallucce e ha detto: “Chi deve decidere? Non esiste più la religione”. Mi ha scioccato la sua riflessione disinvolta che la religione non esiste semplicemente più.
Tutto questo vi sarà familiare, eppure ha gravato pesantemente sulla mia mente mentre preparavo il presente intervento. Ho sentito più e più volte persone dire che ammirano Cristo ma non la chiesa. Non c’era ostilità, né ira, né risentimento, soltanto indifferenza. Ansia è un termine che ho sentito ripetutamente. Molti vanno in analisi. Parlano di vuoto, dell’assenza di un centro. Alcuni affermano che la generazione dei loro genitori li ha lasciati con basse aspettative nei confronti della vita e dubbi riguardo al mettere al mondo dei figli. Conosciamo tutti le complessità che si celano dietro queste osservazioni.
A Yale dirigo attualmente un progetto tra la facoltà di teologia e il dipartimento di psichiatria della facoltà di medicina sulla relazione tra spiritualità e salute mentale. Alcuni miei colleghi conducono ricerche altamente scientifiche sul cervello; altri si concentrano sul comportamento: dipendenza, violenza, depressione e, tragicamente, suicidio. Gli approcci sono diversi, ma le nostre conversazioni convergono sui temi dell’isolamento, dell’alienazione, dell’estasi, della fissazione, dell’ira e del soprannaturale. Siamo giunti alla convinzione condivisa che dobbiamo restare in dialogo al di là dei confini disciplinari.
Questo è ciò che desidero fare oggi: proporre una conversazione tra cristianesimo storico e contemporaneo, soprattutto in riferimento alla giovane generazione che non ha alcun legame con la chiesa o con la vita cristiana. Non intendo suggerire un ritorno al sedicesimo secolo – una mossa del genere non sarebbe soltanto impossibile, ma anche contraria all’etica. Sarebbe un’illusione e un tradimento tanto della Riforma quanto del momento attuale. Tuttavia il passato continua a plasmarci profondamente. Non è confinato agli archivi o ai musei; vive e continua a parlare.
In questo spirito voglio parlarvi di Huldrych Zwingli, non come eroe, ma come un essere umano imperfetto e affascinante, brillante, coraggioso e profondamente fallibile. Non parlerò degli anabattisti o della guerra, sebbene siano inseparabili dalla sua vita. Spero piuttosto di considerare ciò che le sue lotte, le sue convinzioni e i suoi fallimenti potrebbero ancora insegnarci quando riflettiamo sulla fede, sulla alienazione e sulla possibilità di significato nella nostra epoca secolarizzata.
L’indifferenza è una delle condizioni spirituali più pervasive del nostro tempo. In gran parte del mondo occidentale la chiesa non suscita più né opposizione né meraviglia. Essa è invece confrontata con qualcosa di più discreto ma più fatale: il disinteresse. Per molti giovani il cristianesimo appartiene al panorama del mondo dei loro nonni, vestigia di un ordine che ha perso la sua autorità e il suo linguaggio. Non sono in collera con la religione; non sono da essa toccati.
Tuttavia l’indifferenza non è un mero fatto sociologico. È una crisi teologica. Sopraggiunge ogni volta che la chiesa dimentica la sua vocazione profetica: la chiamata a parlare e vivere fedelmente dinanzi a Dio. Quando questa vocazione tace la religione diviene decorativa, un accessorio morale in una cultura che ha già i propri dèi nel consumo e nell’ostentazione di sé. L’indifferenza del mondo è, in parte, un riflesso di quella della chiesa.
La vocazione profetica della chiesa
Dai profeti di Israele alla chiesa primitiva la parola profetica è stata la coscienza del popolo di Dio. Il profeta non predice eventi: interpreta la storia alla luce della verità divina. Il suo compito è di tradurre la Parola di Dio nel linguaggio del suo tempo, di rendere l’eterno percettibile nel particolare.
Huldrych Zwingli afferrò questa vocazione con chiarezza eccezionale. Nel 1529, al culmine della Riforma di Zurigo, scrisse due notevoli prefazioni: una alla Prophetenbibel, la traduzione in tedesco dei profeti dell’Antico Testamento, e l’altra al suo Commento a Isaia in latino. In queste opere ridefinì la profezia non come visione estatica, ma come interpretazione comunitaria delle Scritture. “Nessun singolo individuo vede tutto”, scrisse, “ma ciascuno apporta il proprio contributo all’unico corpo”. In altre parole la profezia è discernimento condiviso, la Parola di Dio accolta e interpretata insieme nella vita della comunità.1
Per Zwingli la parola profetica inizia con l’umiltà. L’interprete deve riconoscere che contribuisce soltanto con “la sua piccola moneta al tesoro di Dio”, un obolus offerto per il bene di tutti.2 La conoscenza, insiste, è necessarium perché ai mortali manca la piena comprensione, tuttavia la verità dev’essere “esposta” (prolatum) e resa pubblica. La verità non è mai proprietà privata: è publicum bonum, bene comune affidato alla chiesa come comunità di ascolto.
Profezia come antidoto all’indifferenza
L’opposto della profezia non è l’incredulità ma il rumore, il discorso privo di significato. Nella sua prefazione a IsaiaZwingli avverte che Dio non gli ha permesso di diventare oyimazōmenos, qualcuno “che fa rumore”, ma piuttostoepigōrizomenos, qualcuno “che parla con comprensione”.3 Difficilmente potrebbe esserci distinzione più rilevante per la nostra epoca, in cui fiumi di parole e immagini minacciano di affogare il significato stesso.
La nostra cultura non è caratterizzata dal silenzio ma dall’incapacità di ascoltare. I giovani oggi abitano un mondo di costante stimolazione, pubblicità incessante, feed algoritmici, commenti senza fine. Il risultato è paradossale: un mondo saturo di comunicazione eppure privo di conversazione, iperconnesso eppure profondamente solo. In un panorama del genere le parole della chiesa suonano spesso come altro rumore nella piazza del mercato.
La teologia profetica di Zwingli affronta direttamente questa condizione. La sua insistenza che “il linguaggio della verità è semplice”, che la Parola deve essere posta “sulla scena pubblica, per quanto semplice e rusticamente vestita”,4 non è bizzarra, è rivoluzionaria. Suggerisce che, in mezzo all’esaurimento dello spettacolo, ciò di cui il mondo ha fame è la verità espressa senza manipolazione. La semplicità profetica diviene una forma di resistenza contro una cultura dipendente dalla performance.
Il panorama spirituale dell’indifferenza
L’indifferenza di molti giovani nei confronti della chiesa maschera qualcosa di più complicato: stanchezza, delusione e brama di autenticità. Vivono in una economia dell’attenzione che tratta l’io come un prodotto. I social media esasperano ogni ansia concernente il valore, la bellezza e l’appartenenza. Il consumismo promette un’identità attraverso la scelta, tuttavia la scelta senza significato produce la paralisi. Il risultato è il dolore della solitudine – non la solitudine della contemplazione, ma l’isolamento dell’esposizione.
In questo clima la chiesa è spesso giudicata come irrilevante perché offre un ulteriore marchio concorrente. Quando promuove l’appartenenza, il benessere spirituale e l’elevazione morale riproduce semplicemente la logica del consumismo, una promessa di soddisfazione senza trasformazione. Ma ciò che la teologia di Zwingli offre, stranamente, è l’opposto: una visione della comunità radicata nell’umiltà, nella gratitudine e nella dipendenza reciproca.
Nella Zurigo di Zwingli la Prophezei, l’incontro quotidiano per la lettura e la discussione delle Scritture, non era uno spettacolo, ma un atto di ascolto condiviso. Studiosi, pastori e cittadini si ritrovavano per confrontarsi sul testo. Era un’educazione alla pazienza, una scuola dell’ascolto. La profezia, per Zwingli, era la pratica disciplinata di ascolto della Parola di Dio in compagnia di altri.
Questa idea, sebbene risalente a cinquecento anni fa, risponde direttamente alle aspirazioni dell’era digitale. In un mondo in cui l’attenzione è costantemente sollecitata, l’invito ad ascoltare, ad ascoltare davvero, può essere in sé un atto di libertà. La chiesa profetica non offre intrattenimento ma attenzione; non rumore ma significato.5
Pietas: un linguaggio dimenticato del cuore
Al centro della visione di Zwingli c’è la virtù della pietas. Per lui questo termine classico, reinterpretato da Erasmo, non significava devozione sentimentale, ma attenzione riverente, umiltà dinanzi a Dio e gratitudine verso gli altri. Unisce l’apprendimento all’amore. La pietas è l’opposto del cinismo; è una disposizione di fiduciosa apertura, l’atteggiamento di coloro che sanno di dipendere dalla grazia.
Zwingli la contrappone all’arroganza e all’isolamento. “Nessuno sa tutto”, scrive, “quello che tutti sanno, lo sanno per il bene comune”. Nella sua vita praticava la gratitudine intellettuale, ringraziando Dio per “gli insegnanti che mi hanno aiutato ad avvicinarmi alla soglia della verità” e definendo “assolutamente maligno” dimenticare il loro aiuto.6 La conoscenza è in sé un atto morale, plasmato dall’umiltà.
Questa visione morale non ha perso nulla della sua potenza. L’io contemporaneo, plasmato dalla competizione e dall’autopromozione, brama una comunità in cui l’apprendimento non umilia, in cui la conoscenza non è usata come un’arma. La comunità profetica immaginata da Zwingli, la republica interpretum, la comunità di interpreti, offre precisamente questo: una visione di illuminazione condivisa in cui la gratitudine prende il posto della rivalità e l’umiltà quello della posa. Per i giovani alienati dall’incessante ostentazione di sé una comunità del genere sarebbe uno shock di grazia.
Radicalismo profetico e sete di trasformazione
Se la teologia della profezia di Zwingli sembra distante dal mondo di YouTube e dagli algoritmi è soltanto perché la chiesa ha dimenticato che cos’è la profezia. La parola profetica non lusinga, bensì disturba. Non ci rassicura che stiamo bene così come siamo, ma ci invita a diventare qualcos’altro.
I giovani, lungi dall’essere indifferenti alla trasformazione, ne hanno un disperato bisogno. Vivono circondati da messaggi di affermazione, “sii te stesso”, “segui la tua verità”, tuttavia percepiscono il vuoto dietro di essi. Essere esortati semplicemente ad affermare l’io significa essere condannati a restare entro i suoi limiti. Ciò che attira l’immaginazione non è l’affermazione ma la trasfigurazione: la possibilità di un cambiamento reale, doloroso e redentore.
Questo è ciò che la profezia offre. Il “no” profetico all’ingiustizia, alla vanità, all’autocompiacimento non è crudeltà ma misericordia. È la parola che fa spazio a qualcosa di nuovo. Quando Zwingli pose la Scritture “sulla scena pubblica, per quanto semplici e rusticamente vestite”, non era in cerca di rilevanza; stava demolendo la messinscena, dichiarando che la verità non ha bisogno di mascheramenti. Il suo era un atto radicale, poiché rimuoveva il linguaggio del potere e offriva al suo posto la semplicità della verità.
Oggi è necessaria la stessa radicalità. La chiesa non dovrebbe scusarsi per la sua differenza rispetto al mondo, ma incarnarla. I tentativi di essere alla moda, di sembrare un marchio, di mutuare l’idioma dell’intrattenimento sono destinati al ridicolo. I giovani li riconoscono all’istante. Le parodie online della cultura della “chiesa cool” sono divertenti perché corrispondenti al vero: rivelano la disperazione di istituzioni che hanno perso fiducia nel loro linguaggio.
Ciò che suscita rispetto non è l’imitazione ma l’integrità. La chiesa che osa dire una parola che costa, che dice no all’avidità, alla vanità, all’idolatria dell’io, verrà ascoltata proprio perché non assomiglia a tutto il resto. Una chiesa che dice la verità sul peccato, sul perdono e sulla grazia; che chiama le persone non all’espressione di sé ma all’offerta di sé; che insiste sul fatto che la libertà si trova nell’obbedienza; questa è la chiesa che coglierà di sorpresa gli indifferenti e attirerà la loro attenzione.
La visione di Zwingli era radicale proprio in questo senso. La sua republica interpretum non era una stanza dell’eco ma una comunità di trasformazione, dove l’atto di ascoltare la Parola trasformava coloro che ascoltavano. “Nessuno sa tutto”, scrisse, “e ciò che tutti sanno, lo sanno per il bene comune”. Lo scopo non era di confermare un’identità di credente, ma di formare un nuovo io, uno caratterizzato da umiltà, riverenza e gratitudine.
La voce profetica, allora e adesso, si oppone all’appiattimento del mondo nell’affermazione di sé. Proclama che la realtà è più dell’io, che la verità non è uno stato d’animo ma una chiamata. Si rifiuta di mascherare la sua diversità e in questo rifiuto sta la sua potenza.
Per una generazione stanca di ironia e bramosa di significato la rilevanza della chiesa non risiederà nell’essere cool, ma nell’essere autentica. La sua radicalità non deriverà dallo stile, ma dalla santità. Parlare profeticamente è ricordare al mondo che la trasformazione è ancora possibile, che gli esseri umani possono cambiare, che la misericordia è reale e che la Parola che un tempo scosse Zurigo può ancora scuotere la terra.7
Il costo di una vita degna di essere vissuta
Zwingli non offrì mai un’opzione facile ai suoi ascoltatori. Essere cristiani, insisteva, significa vivere una vita disciplinata, lottare quotidianamente contro le proprie debolezze e fallire spesso. La fede non era una garanzia di serenità ma una battaglia che dura tutta la vita tra lo Spirito e la carne, tra ciò che siamo e ciò che siamo chiamati a diventare. Nei suoi sermoni e commenti di Zurigo la vita cristiana è una scuola di obbedienza in cui si impara, a fatica, a dipendere dalla grazia.
È proprio questo realismo a rendere la sua visione così convincente. Non prometteva conforto; prometteva significato. Sapeva che molti non avrebbero accolto il suo messaggio, che la sua insistenza sul pentimento e sull’umiltà avrebbe tanto respinto quanto attratto. Tuttavia ciò non attenuò la sua convinzione che la verità doveva essere detta, perché è dura. Il Vangelo, per Zwingli, non è una rassicurante storia di accoglienza, ma la chiamata a un’esistenza nuova che comincia soltanto quando la vecchia esistenza muore.
La chiesa moderna spesso lo dimentica. È diventata ansiosa di fronte alle difficoltà, preferendo l’accessibilità alla profondità. Tuttavia l’onesta ammissione che la fede è esigente, che richiede disciplina e conversione quotidiana, può essere proprio ciò che la rende di nuovo credibile. Il mondo contemporaneo è pieno di promesse che la felicità può essere ottenuta senza sforzo, con il giusto stile di vita, il giusto atteggiamento mentale, il giusto marchio. Quello che i giovani capiscono immediatamente è la disonestà di tali promesse.
Miroslav Volf lo ha espresso chiaramente in un recente libro, Life Worth Living (“Vita degna di essere vissuta”): lo scopo della vita non è il conforto o l’autocompiacimento, ma il significato e il significato comporta sempre lotte, fallimenti e la possibilità della gioia.8 La chiesa, se è fedele, deve dire la stessa cosa. Non deve offrire un facile moralismo o una serie di divieti, ma una visione della vita che comporta un prezzo. Il messaggio non può essere: “Puoi avere tutto ciò che desideri e chiamarlo fede”. Il messaggio dev’essere: “Puoi diventare qualcosa di più di ciò che sei, ma ti costerà tutto”.
Zwingli lo aveva capito perfettamente. Sapeva che la chiamata radicale al discepolato avrebbe tanto scandalizzato quanto ispirato. Molti dei suoi contemporanei lo respinsero; altri lo denunciarono come fanatico. Tuttavia egli credeva che la chiarezza della Parola avesse più importanza della sua popolarità. Parlare onestamente significava dare alle persone la dignità di sapere che cosa respingevano. Era preferibile, pensava, essere respinti per ciò che il Vangelo è che essere accettati per ciò che non è.
Lo stesso è vero oggi. I giovani non si riverseranno improvvisamente nelle chiese né dobbiamo aspettarci che lo facciano. Ma quando incontrano una comunità che osa parlare in modo radicale e dire che una vita degna di essere vissuta è una vita plasmata dall’amore, dal sacrificio e dal pentimento, sanno almeno che c’è un’alternativa al moralismo esausto della nostra epoca. Potranno non credere, ma capiranno che cosa vuol dire credere.
La chiesa non può raggiungerli impartendo moniti morali che suonano come minacce. Tali proibizioni sono inefficaci se avulse da una visione della vita che dia un senso alla rinuncia. Ciò che attirerà l’attenzione è la radiosità della convinzione, la sensazione che qui ci sia qualcosa per cui vale la pena lottare, una verità che non è in vendita. La profezia, in questo senso, non è una questione di popolarità; è una questione di integrità. Talvolta la parola radicale offenderà, ma non è l’indignazione la nemica della fede, lo è l’indifferenza. L’indignazione prova almeno che la Parola è stata ascoltata.
Il radicalismo di Zwingli non è mai stato una questione di sdegno; era una questione di verità. Egli credeva che la chiesa avesse il compito di ricordare al mondo che la vita ha una struttura, che la libertà ha una forma, che la grazia non è indulgenza ma trasformazione. Proclamarlo non è respingere il mondo, ma amarlo tanto da dirgli la verità. Se la chiesa riesce a ritrovare quel coraggio, a dire no dove il mondo si aspetta applausi e sì dove il mondo dispera, scoprirà che anche coloro che se ne andranno, se ne andranno cambiati. Avranno visto che c’è un’altra possibilità, un’altra visione di ciò che significa essere umani. E nel lungo silenzio dell’epoca, questa visione riecheggerà.
Una chiesa profetica non riempirà i suoi banchi dall’oggi al domani. Ma risveglierà la memoria. Mostrerà che la Parola di Dio ha ancora il potere di turbare, di guarire e di suscitare vita nuova. In una cultura che ha dimenticato che cosa significa vivere una trasformazione, questo potrebbe rappresentare l’inizio della fede stessa. (Per gentile concessione degli organizzatori del Simposio “Il futuro della chiesa riformata in Svizzera”; trad.: G.M. Schmitt)
________________________________________
1. Huldrych Zwingli, Praefatio in Esaiam Prophetam, in Opera Latina (Corpus Reformatorum XCIII), discusso in Bruce Gordon, “The Emergence of Reformed Spirituality: Zwingli in 1529”, Zwingliana (in via di pubblicazione, 2025).
2. Zwingli, Praefatio in Esaiam Prophetam, §4.
3. Ibid., §12.
4. Ibid., §10.
5. Vedi Byung-Chul Han, La scomparsa dei riti. Una topologia del presente (Milano: nottetempo, 2021), 34–36 (della versione in inglese), sull’ascolto e la perdita di risonanza nella cultura digitale.
6. Zwingli, Praefatio in Esaiam Prophetam, §25.
7. Vedi Hartmut Rosa, Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World (Cambridge: Polity, 2019), in particolare 281–92; e Charles Taylor, L’età secolare (Milano: Feltrinelli, 2009), 730–42 (della versione in inglese).
8. Miroslav Volf, Life Worth Living: A Guide to What Matters Most (New York: Convergent Books, 2023), 18–25.