I contadini non volevano la guerra
Cosa successe di preciso 500 anni fa?

Cosa successe di preciso 500 anni fa?

Il 500. anniversario della guerra dei contadini ha portato con sé un gran numero di mostre, progetti di ricerca, congressi e pubblicazioni. Matthias Hui e Kurt Seifert della rivista zurighese Neue Wege hanno condotto una doppia intervista con due ricercatori dall’approccio molto differente quando si tratta della sollevazione dei contadini del 1525 capeggiata da Thomas Müntzer, antagonista di Martin Lutero.
L’uno, Thomas Kaufmann, si concentra sulla messa in scena mediatica delle varie posizioni, resa possibile grazie alla tecnica della stampa; l’altra, Janine Maegraith, si occupa di storia sociale della società rurale, del suo quadro giuridico e delle sue disuguaglianze. Una lunga conversazione da leggere tutta d'un fiato. Per gentile concessione di Neue Wege.
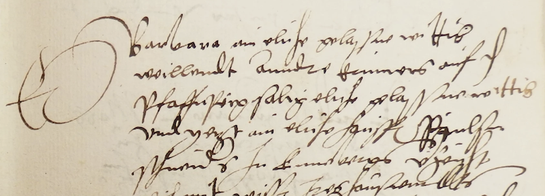
Thomas Kaufmann, qual è secondo lei il nocciolo degli eventi del 1525?
TK Io metto a fuoco la storia concettuale della guerra dei contadini. Nella percezione della maggioranza dei contemporanei, che al tempo si espressero a mezzo stampa, la guerra dei contadini era una sollevazione, una rivolta contro la società per classi e le ingiustizie che ne derivavano. Dal punto di vista degli stessi contadini la guerra dei contadini era un movimento trasversale globale volto a far valere rivendicazioni sociali e giuridiche fondamentali. Queste erano una reazione al fatto che, nei decenni precedenti le sollevazioni, la condizione giuridica dei contadini era notevolmente peggiorata.
Janine Maegraith, lei studia la società rurale del Tirolo nel 16. secolo. Come descriverebbe gli eventi del 1525?
JM Concordo pienamente con quanto esposto da Thomas Kaufmann. Dal punto di vista della sollevazione dei contadini in Tirolo, la regione oggetto delle mie ricerche, dove la condizione giuridica dei contadini era diversa, per esempio, rispetto a quella nell’Alta Svevia, aggiungerei che nel 1525 la popolazione contadina prese coscienza del fatto che era possibile ricorrere a strumenti giuridici per rafforzare la propria situazione giuridica e opporsi ai signori, ma anche che tali strumenti erano limitati. I contadini compresero altresì che gli istituti monastici si procuravano entrate ben oltre la loro vera funzione e sfruttavano la popolazione.
TK Questo sfruttamento è ben esemplificato, per esempio, dal principato abbaziale di Kempten im Allgäu: gli abati del luogo si avvalsero di documenti giuridici falsi per strumentalizzare il diritto vigente per far valere nei confronti dei contadini diritti di cui quest’ultimi non erano a conoscenza nel quadro del diritto tradizionale non scritto.
JM Uno sviluppo storico interessante, che portò a sollevazioni e scontri violenti, alla cosiddetta guerra dei contadini, è il fatto che gli strumenti giuridici esistenti per la risoluzione dei conflitti, i processi di negoziazione giudiziale ed extragiudiziale, non furono sufficienti per giungere a un accordo.
Perché parla di “cosiddetta” guerra dei contadini?
JM Sono storica della società e del genere. Mi concentro sulla storia degli eventi. La ricostruzione degli eventi sulla base di fonti provenienti in massima parte dalle autorità è piuttosto discutibile. Perché tale approccio esclude le persone e i contesti non menzionati nelle fonti. Noi storici della società studiamo le condizioni quadro e il contesto. Perciò abbiamo problemi con il termine “contadino” perché, appunto, gli eventi non hanno riguardato soltanto “i contadini”, bensì l’intera popolazione rurale, abbienti e non abbienti, uomini e donne. Riteniamo problematico anche il termine “guerra”, che è molto complesso dal punto di vista della storia del diritto. Nella descrizione degli stessi protagonisti compare invece il termine “sollevazione”. Stiamo dunque attenti all’espressione “guerra dei contadini” e cerchiamo di differenziare.
TK È altresì interessante che nel dibattito più recente è scomparso l’aggettivo “tedeschi”. Si è sempre parlato di “guerra dei contadini tedeschi”. Da quando a metà del 19. secolo il teologo e storico Wilhelm Zimmermann pose l’accento sul legame tra la guerra dei contadini e la nazione, questo legame è stato eccessivamente sottolineato. Egli era infatti molto interessato a un contesto di riferimento politico per gli sforzi volti alla democratizzazione della Germania prima del 1848. La ricostruzione della guerra dei contadini da parte dell’ex nazista Günther Franz, che per lungo tempo era quella di riferimento, nel 20. secolo ha portato avanti in vari modi questa narrazione. Nelle fonti e nelle rivendicazioni dei contadini nel 16. secolo non trovo quasi alcun riferimento alla narrazione nazionale, che era tuttavia assolutamente presente, se pensiamo all’appello di Lutero Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca.
E lei, Thomas Kaufmann, come la vede?
TK Per me la guerra dei contadini è il risultato di una messa in scena mediatica. La guerra dei contadini, nel senso in cui la intendo io, non può essere dissociata dagli attori urbani che hanno agito come intermediari tra l’“opinione pubblica” e gli attori rurali. Ne sono esempi Christoph Schappeler e Sebastian Lotzer, ritenuti i presunti autori dei “Dodici Articoli” e del trattato An die Versammlung gemeiner Bauernschaft in Memmingen. Si tratta di documenti incredibili, in quanto nelle loro rivendicazioni sociali, economiche, giuridiche, politiche e religiose rappresentano una richiesta unica e rivoluzionaria: la pretesa di dare espressione universale agli interessi di tutti i contadini. La pubblicazione e ricezione di quelle istanze fu molto rapida. Il movimento di rivolta, che era in generale fortemente riferito a circostanze specifiche locali o regionali, si trasformò in un incendio di vaste proporzioni.
Thomas Kaufmann, si spingerebbe a dire che la popolazione contadina non era affatto l’attore decisivo?
TK L’idea che nel 1525 i contadini fossero insorti, per così dire, contro il resto del mondo è completamente anacronistica o persino social-romantica. Se si considera la guerra dei contadini un vasto fenomeno transregionale, allora gli attori decisivi sono quelli che hanno permesso la diffusione di questi testi e l’influenza reciproca tra le diverse regioni in rivolta. E non dobbiamo dimenticare che la piccola nobiltà ha svolto un ruolo non trascurabile in molti scenari di rivolta. L’agitazione ha funzionato perché ha trovato risonanza nella quotidianità contadina. Se non avesse avuto tale risonanza i contadini non si sarebbero messi in marcia. L’azione degli influencer intellettuali doveva tener conto delle condizioni di vita dei contadini. Dalla Creazione veniva fatto derivare il diritto all’uso dei beni comuni, il libero accesso di ognuno a pesci, uccelli, selvaggina, legno e acqua. Dalla redenzione operata da Cristo si derivava che nessuno doveva essere sottomesso a qualcun altro, perché siamo tutti redenti e quindi tutti liberi allo stesso modo. Quando un contadino sente certe grandi idee è naturale che ne sia toccato, perché riguardano il nocciolo stesso della sua esistenza.
JM Io non minimizzerei a tal punto il ruolo attivo della popolazione contadina. Non dobbiamo dimenticare che circa il 90% della popolazione era rurale. La maggior parte dei partecipanti agli eventi del 1525 erano contadini e campagnoli e avevano i loro buoni motivi per prendere parte alla sollevazione. Non dobbiamo considerare soltanto i “Dodici Articoli”, ma anche i numerosi elenchi di richieste esistenti. Ogni territorio del Tirolo, dell’Alta Svevia o anche dell’attuale Svizzera aveva un proprio elenco di rivendicazioni.
TK Concordo, ma questi elenchi di richieste locali e regionali non sono mai stati stampati. Le sole rivendicazioni stampate sono i “Dodici Articoli”. Non possiamo risalire al vasto fenomeno che chiamiamo “guerra dei contadini” dai singoli elenchi di richieste locali scritti a mano. In Turingia, per esempio, con la massima naturalezza fecero propria la richiesta di abolizione della servitù della gleba, anche se non c’era la servitù della gleba in Turingia. Siamo qui in presenza di un pacchetto di richieste resosi autonomo. Oggi, nell’interpretazione dei “Dodici Articoli”, si parla anche di una sorta di proclamazione dei diritti fondamentali: determinate forme di sottomissione e di dipendenza diventano inaccettabili per i contadini. La caratteristica specifica della cosiddetta guerra dei contadini, rispetto alle rivolte contadine precedenti alla Riforma, è la pubblicistica, la dinamica risultante dalla rivoluzione mediatica. La diffusione del movimento di rivolta nella Germania centrale e sudoccidentale coincide quasi perfettamente con le zone in cui la comunicazione tipografica era più capillare. Lì dove si stampava, lì c’erano rivolte.
JM Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la grande maggioranza della popolazione rurale non sapeva né leggere né scrivere. Molto si diffondeva mediante la comunicazione orale, come possiamo constatare anche nelle valli del Tirolo. La varietà di questo movimento e il numero considerevole di rivendicazioni di vario genere sono il risultato di diverse forme di comunicazione. Non possiamo documentare nel dettaglio che cosa è avvenuto guardando solo agli scritti stampati, alla memorizzazione di quegli scritti, ma va tenuto conto anche di cosa è avvenuto mediante la trasmissione orale. Dobbiamo mantenere uno sguardo equilibrato sull’insieme.
Lei, Janine Maegraith, parla della necessità, nella ricerca, di decentrare lo sguardo. Bisogna concentrarsi meno sul campo da gioco e più sullo sfondo, su coloro che stanno nelle case e all’ombra. In che modo questo approccio le permette di acquisire nuove conoscenze?
JM In molte regioni si fa ancora troppo poca ricerca sulla società rurale. Il nostro progetto di ricerca in Tirolo al Centro di storia regionale di Bressanone studia il contesto sociale ed economico e in particolare le economie domestiche. Teniamo ovviamente conto della più recente comprensione economica e storica in materia di economie domestiche, secondo la quale tutte le persone in un sistema sono coinvolte e hanno i propri compiti da svolgere. A partire dai regesti giudiziari cerchiamo di ricostruire la quotidianità delle economie domestiche, determinando chi aveva quale ruolo, ossia uomini, donne e bambini. Qual era la prassi giuridica, il ricorso alle opzioni legali da parte delle persone interessate? A tal fine utilizziamo come fonti soprattutto i cosiddetti libri d’archiviazione, i verbali giudiziari, che documentano tutti i cambiamenti di proprietà, per esempio mediante matrimonio, trasmissione ereditaria, donazioni tra persone viventi, testamenti, ma anche vendite e locazioni. Con queste fonti di “diritto civile” possiamo ricostruire rapporti di proprietà, diritti d’uso, diritti ereditari, ma anche le condizioni materiali di vita delle economie domestiche. In Tirolo la separazione dei beni nel matrimonio era prestabilita dalla legge. I coniugi portavano i loro beni nel matrimonio e li condividevano, ma conservavano il diritto di proprietà sulla loro parte e in caso di morte non godevano di alcun diritto successorio sulla parte della persona defunta. La trasmissione ereditaria veniva regolata in modo più aperto, così che si trovavano aree in cui la trasmissione della proprietà era indivisa e altre in cui era divisibile. Le fonti mostrano un’ampia gamma di prassi giuridiche, per esempio vedove che ottenevano l’usufrutto della terra del defunto marito e assumevano la gestione della fattoria, oppure mogli che con il loro patrimonio partecipavano attivamente all’acquisizione di beni immobili.
TK Trovo straordinariamente interessante questo tipo di storia sociale microstorica. Ma come si arriva dalla ricostruzione della società rurale e delle sue strutture alla guerra dei contadini?
JM Il nostro obiettivo in realtà non è la guerra dei contadini, bensì una descrizione storica differenziata della società rurale e dell’epoca. C’è ovviamente bisogno di una storia degli eventi, ma non deve essere l’unica narrazione. C’è una stretta connessione con la critica delle fonti: non sono d’accordo con l’interpretazione che presenta la guerra dei contadini come un evento molto virile, maschile. Si tratta di mascolinità, di fratellanza, è vero. Ma se mi concentro su questo, tutto il resto della società finisce in un vuoto. Noi cerchiamo di colmare questo vuoto: qual era la realtà della vita? Perché nelle fonti le donne non vengono quasi mai menzionate? E come leggiamo le fonti? Le donne dovevano per esempio continuare a gestire la fattoria quando gli uomini partivano. Così analizzo anche i verbali degli interrogatori condotti in relazione alla liberazione del capo dei contadini Peter Pässler nel maggio del 1525 e ai successivi saccheggi di Novacella, del castello di Rodengo e del Palazzo vescovile di Bressanone. Gli uomini furono interrogati, in parte sotto tortura, sui saccheggi, i piani di insurrezione e la diffusione delle informazioni tra i contadini. Come luoghi di propaganda menzionarono spazi pubblici come le piazze, il forno, ma anche le fattorie, il che fa supporre una conoscenza e un’eventuale partecipazione molto maggiori. La domanda che si pone è: come mai certe cose vengono dette e altre no e perché le donne non vengono menzionate?
TK La critica delle fonti implica la consapevolezza del tipo di tradizione in nostro possesso. Si tratta in gran parte della tradizione dei Signori, una storia scritta dalla parte dei vincitori. La voce più autentica dei contadini, dei contadini e ancor di più delle contadine, è estremamente difficile da cogliere.
JM Proprio per questo motivo vogliamo ricostruire la storia sociale. Se ci avviciniamo di più alla vita reale, in particolare mediante l’analisi della prassi giuridica e delle condizioni materiali di vita delle economie domestiche rurali, allora riusciremo a riempire un po’ questo vuoto.
Entrambi avete parlato ancora poco di teologia, del contesto della Riforma. Che relazione c’è con la guerra dei contadini?
TK È chiaramente parte integrante della Riforma. Senza l’agitazione riformatrice, massicciamente presente dal 1520, la guerra dei contadini è per me inimmaginabile. Nel contesto della Riforma sono state avanzate richieste e lanciati slogan, non da ultimo quello della libertà dei cristiani. Questi sono stati interpretati dai contadini in maniera probabilmente molto diversa da quelle che erano le intenzioni del loro autore, Martin Lutero. Un secondo punto: la Riforma ha formulato una critica fondamentale alla società del tempo e in particolare al ruolo del clero. E questo anticlericalismo, già presente prima della Riforma ma adesso messo a fuoco, è un tratto basilare dell’insurrezione contadina: vengono presi di mira i complessi monastici. Nulla, assolutamente nulla nel messaggio della Riforma può più legittimare il clero che detiene il potere ed esige dai contadini il pagamento di imposte. Quindi la Riforma ha contribuito in modo massiccio alle rivendicazioni dei contadini – contrariamente alla narrazione diffusa soprattutto da Martin Lutero che non vi era alcuna relazione tra le due cose e che era tutto un malinteso. Questa narrazione è stata costantemente ribadita nella storiografia luterana e necessita di una correzione radicale.
JM Anche se in Tirolo l’insurrezione contadina non ebbe inizio con le idee della Riforma, senza questa base ideologica ancorata nella Riforma, senza l’atteggiamento anticlericale e antimonastico che permise di pensare in modo radicale, il movimento non sarebbe proseguito. In Tirolo non si voleva necessariamente sciogliere i monasteri, ma la loro funzione di potere territoriale non venne più riconosciuta. Con le idee della Riforma fu possibile formulare la critica dello sfruttamento che ne derivava – in Tirolo influenzata più dal riformatore zurighese Zwingli che da Lutero.
TK Ciò che nella tradizione riformata è molto più marcato e che ha trovato consenso nei comuni rurali è quello che lo storico Peter Blickle ha chiamato “comunalismo”. Si tratta della visione di una cosiddetta comunità repubblicana. Questa non sarà dominata da strutture di potere. Saranno piuttosto le singole persone e famiglie, le economie domestiche a parteciparvi. Particolare impulso al riguardo fu dato in particolare da Zwingli, anche alla luce dell’esperienza della Repubblica urbana di Zurigo. Vedo i “Dodici Articoli” più nella sfera d’influenza del pensiero zwingliano che in quella delle idee di Lutero, che dal 1523/24 si è espresso in maniera molto conforme all’autorità.
Lei, Thomas Kaufmann, descrive come il riformatore radicale Thomas Müntzer abbia acquisito lo “status di eroe”: attraverso la contrapposizione mediatica di Müntzer con Lutero, fortemente incoraggiata dallo stesso Lutero e che è perdurata per tutta la storia della sua influenza. Il tema della guerra dei contadini è stato sempre strettamente legato alla sua figura. Come giudica questo fatto dal punto di vista odierno?
TK Il destino di Thomas Müntzer è che la sua figura è stata ridotta dalla storia della ricezione alle sue ultime settimane di vita nella guerra dei contadini. Questa storia è stata dapprima negativa a causa di Lutero e dei suoi compagni ed è poi stata ribaltata nel suo opposto da Friedrich Engels con La guerra dei contadini in Germania, ma l’antitesi è rimasta. Müntzer è una figura estremamente sfuggente, unica nel suo tempo e con una retorica molto particolare. Non conosco nessun autore degli inizi del XVI secolo che abbia scritto complessi testi in tedesco come Thomas Müntzer. È straordinariamente difficile da comprendere e alla sua epoca non ha avuto pressoché alcuna risonanza mediatica. Cercò anche, con un viaggio nel sud-ovest fino a Basilea, di entrare in contatto con gli ambienti rurali, ma evidentemente non funzionò. Al suo ritorno all’inizio di febbraio del 1525 si ritrova a Mühlhausen nel ruolo di agente provocatore delle resistenze che andavano formandosi. In seguito Müntzer apparirà come il grande agitatore che ha fatto scoppiare la guerra dei contadini. In quanto apocalittico Müntzer aveva una concezione teologica dei cambiamenti imminenti e in effetti si aspettava nel contesto delle sollevazioni contadine l’avvento della svolta decisiva della storia. Come nella Bibbia le schiere celesti combattono all’improvviso a fianco del popolo israelita, così sarebbe dovuto accadere anche aFrankenhausen. Definirei Müntzer come un gigante apparente. Troviamo questa figura in un meraviglioso libro di Michael Ende (Le avventure di Jim Bottone, N.d.T.): più ci si allontana, più grande è il fenomeno e più ci si avvicina, più diventa piccolo. Più io mi avvicino al personaggio storico di Müntzer, tanto più irrilevante e privo di efficacia mi appare nella sua epoca. Se Lutero non lo avesse attaccato nei suoi scritti, oggi nemmeno ci ricorderemmo di lui.
JM Con il concetto dell’eroe lei solleva un punto importante, ma la sua caratterizzazione di Müntzer è probabilmente piuttosto offensiva.
TK Sì, certo, ci sono ancora gli entusiasti di Müntzer. Anche io lo trovo estremamente interessante. Ma la mia disponibilità a identificarmi con figure del XVI secolo è stata compromessa nel corso delle ricerche su questo periodo storico.
Janine Maegraith, che cosa può dirmi dei riformatori radicali nella sua area di ricerca, il Tirolo? Come valuta il loro impatto – anche al di là della guerra dei contadini?
JM In Tirolo ci fu una grande ondata di reazione da parte delle autorità e gli anabattisti, uomini e donne, vennero esiliati oppure uccisi. La repressione fu molto violenta. Io mi occupo per esempio anche degli inventari delle economie domestiche e ho notato che i libri sono pressoché assenti, ma c’è un motivo: i libri venivano probabilmente confiscati. Il grande “eroe” della regione è il “capo dei contadini” Michael Gaismair. Trovo tuttavia problematico concentrare la ricerca sulle singole persone. Dobbiamo dimenticarci di eroi ed eroine. Per me gli approcci di ricerca della storia sociale sono più pertinenti, tanto più che in Tirolo i tribunali o i comuni erano rappresentati nella Dieta e godevano quindi di una rappresentanza politica. Il pensiero comunalista aveva lì già una base, il che può essere studiato anche analizzando la gestione dei beni comuni e l’accesso a questi beni.
Anche il movimento anabattista era parte integrante della guerra dei contadini e del movimento riformatore del 1525?
TK Nella ricerca sugli anabattisti siamo oggi ampiamente tenuti a una prospettiva ricostruttiva “poligenetica”: ciò significa che vediamo radici dell’anabattismo tanto in Sassonia, con i riformatori Müntzer e Karlstadt, quanto a Zurigo. A Zurigo si trovano nell’ambiente degli ex seguaci di Zwingli, del quale hanno rifiutato il modello statalistico di Riforma ed erano dell’idea che le direttive della nuova organizzazione della chiesa dovessero essere fissate dalla comunità e non dal Consiglio zurighese. L’anabattismo ha molto a che fare con gli impulsi di “riforma della comunità”, cioè con la volontà da parte di singoli individui e comuni di gestire la religione autonomamente. Per tutta una serie di capi anabattisti come Hans Denck, Hans Hut, Balthasar Hubmaier o Ludwig Hätzer è possibile documentare uno stretto legame con la guerra dei contadini. Erano veterani della guerra dei contadini, erano stati coinvolti nelle rivolte e avevano difficoltà a riadattarsi alla società per ceti. La coincidenza di entrambi gli anniversari – il primo battesimo di fede a Zurigo nel gennaio del 1525 e la guerra dei contadini – non è casuale e ha un fondamento nella storia della Riforma. Il 1525 è l’anno in cui si fa tangibile e visibile la tendenza al nonconformismo, alla disconformità nei confronti di una Riforma dall’alto che si sta affermando.
Il suo libro “Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis” si conclude con una nota pessimistica: “Certamente la resistenza contro la violenza imposta è un diritto elementare e un male necessario. Non cambia tuttavia il fatto che la guerra in sé non ha senso, anzi è il male stesso. Anche la guerra dei contadini fu senza senso”. Non c’è davvero altra conclusione da trarre dallo studio degli eventi del 1525? Una posizione del genere non rischia di confermare l’atteggiamento di Lutero, secondo il quale ogni cristiano o cristiana deve ubbidire ciecamente a ogni autorità?
TK Non mi sembra che sia possibile osservare qualcosa come un sostanziale miglioramento della situazione sociale e giuridica della popolazione rurale in seguito alla guerra dei contadini. Non possiamo nemmeno dire che dopo la guerra dei contadini le cose siano peggiorate. Durante la guerra dei contadini centomila persone furono massacrate nella maniera più barbara e questo in situazioni e configurazioni in cui probabilmente non avevano alcuna possibilità sul piano militare. Fu inscenata una spaventosa giustizia del vincitore che aveva soprattutto lo scopo di intimorire e rendere così impossibile che un evento del genere si verificasse di nuovo. Onestamene trovo tutto questo piuttosto crudele e assolutamente senza senso. Forse questa formulazione tranchant deriva dal rimprovero che io faccio alla ricerca sulla guerra dei contadini, quello cioè di aver portato avanti dalla metà del XIX secolo una ricostruzione retrospettiva del significato della stessa. Cioè, di aver trasformato la rivoluzione dell’uomo comune, alla luce di un’ideologia marxista della storia, in una rivolta dotata di significato. Perché la guerra dei contadini è stata infatti interpretata come una “rivoluzione protoborghese” e quindi come preludio agli sconvolgimenti volti a produrre una società migliore che sarebbero poi dovuti sfociare nella rivoluzione proletaria e nella costruzione del socialismo. Una tale interpretazione storico-filosofica è priva di qualsiasi fondamento storico. Perciò non voglio portare avanti una tale narrazione. Forse anche perché non abbiamo più bisogno di alcuna narrazione della guerra dei contadini per affermare la nostra propria volontà di una società liberale e democratica e possiamo invece ricorrere ad altre esperienze storiche.
JM Capisco che cosa intende: la storia non deve mai essere legittimata retroattivamente. Ma quando lei dice che la guerra dei contadini fu senza senso, in realtà aderisce a questo modo di pensare, perché viceversa quasi la delegittima. Si tratta per me di analizzare quali erano i contesti, che cos’è accaduto e quali sono state le conseguenze e non di valutare gli eventi. Per me è interessante conoscere quali processi di regolamentazione giuridica sono seguiti, quali conseguenze sociali ed economiche la guerra dei contadini ha avuto. O quali movimenti sono sorti nell’ambito della Riforma. Non mi domando se si sia trattato di uno strumento sensato. I contadini non volevano la guerra.
TK La frase del mio libro che ha citato si trova nel capitolo conclusivo, il cui titolo è Il crepuscolo degli eroi. In quelle pagine dimostro che la maggior parte degli eroi della guerra dei contadini non erano contadini. Già soltanto questo mostra che siamo in presenza di una visione distorta del fenomeno in una storia della ricezione molto complessa ed estremamente discutibile. Non è mia intenzione creare altre narrazioni eroiche in relazione alla guerra dei contadini. La formulazione “senza senso” si riferisce al fatto che sono state diffuse narrazioni significative in relazione alla guerra dei contadini dalle quali ho voluto dissociarmi. Da me potrà però leggere come dopo il 1525 la tendenza a una Riforma guidata dalle autorità diventerà assolutamente dominante. In tal senso la guerra dei contadini fornirà a Martin Lutero l’argomento finale contro la riforma delle comunità locali.
In conclusione vorremmo farvi una domanda più personale. Che cosa vi spinge, nell’ambito del vostro lavoro scientifico, a occuparvi di quest’epoca, degli avvenimenti del 1525? Che cos’è che continua ad appassionarvi?
TK La mia risposta è semplice. Mi affascina il fatto di poter ricostruire quella grande serie di eventi, entrata nella memoria storica con il nome di “guerra dei contadini”, come un fenomeno indotto dai media. Io credo che si possa dimostrare che – per usare una formulazione patetica – per la prima volta nella storia dell’umanità è stato il mezzo stampa a dare il via a una serie di eventi di questo tipo. In questo modo si è afferrata appieno, per la prima volta, la forza esplosiva di questa tecnica di riproduzione che chiamiamo stampa.
JM Io sono invece piuttosto affascinata dal tempo. Trovo davvero entusiasmante gettare lo sguardo su questo periodo protocapitalistico, con l’espansione del commercio e i mutamenti nel sistema giuridico. In Tirolo, poco dopo, fu istituito il primo ordinamento giuridico. Si fece riferimento al vecchio diritto territoriale. Trovo appassionante l’evoluzione della storia giuridica sociale: vedere come cambiava la prassi giuridica a livello locale, come i conflitti, per esempio sul diritto di proprietà, si negoziavano e venivano stipulati contratti di conciliazione e chi erano le persone coinvolte. A livello locale trovo molto interessanti gli sviluppi economici che possiamo rilevare nelle famiglie. Tutto è interconnesso e si tratta di mettere in relazione queste conoscenze con la narrazione della guerra dei contadini. Che cosa accade in quel momento? Perché quel momento è così importante?
Ne estrapola anche informazioni utili per il presente?
JM Prima di tutto l’importanza della comunicazione tra basso e alto, la questione del dialogo. Per esempio quando si tratta della disuguaglianza crescente. Come affrontiamo questo problema, questi conflitti a livello sociale ed economico, su scala piccola e grande? Io vivo in Inghilterra, dove osserviamo un incremento estremo delle disuguaglianze. In secondo luogo la gestione delle risorse, della popolazione rurale, dell’agricoltura, dell’approvvigionamento. Questa tematica si sta straordinariamente inasprendo con il cambiamento climatico. Su tali questioni non possiamo semplicemente imparare dallo studio storico della guerra dei contadini e della sua epoca, ma possiamo sensibilizzare sui problemi che abbiamo oggi e che si intensificheranno sempre di più. ●
Thomas Kaufmann, nato nel 1962, è un teologo evangelico, titolare della cattedra di Storia della chiesa all’Università di Gottinga e direttore della Biblioteca statale e universitaria di Gottinga. I suoi principali settori di ricerca sono la storia della Riforma e la storia dell’età moderna. Dopo la pubblicazione di libri su Martin Lutero e sugli anabattisti, nel 2024 ha dato alle stampe il saggio Bauernkrieg. Ein Medienereignis, “La guerra dei contadini. Un evento mediatico”.
Janine Maegraith, nata nel 1970, è una storica sociale indipendente e ricercatrice presso il Newnham College di Cambridge. Le sue aree di ricerca comprendono la storia dei consumi e della cultura materiale, le forme dei trasferimenti di proprietà, le successioni e la struttura delle economie domestiche, la storia e lo sviluppo degli ordini religiosi femminili e gli effetti della secolarizzazione. Il suo attuale progetto di ricerca sull’economia dei nuclei familiari presso il Centro di storia regionale di Bressanone riguarda la società rurale in Tirolo nel XVI secolo.
Hanno condotto la conversazione Matthias Hui, nato nel1962, co-caporedattore di Neue Wege, teologo e membro di comitato dell’Istituzione svizzera per i diritti umani ISDU, e Kurt Seifert, nato nel 1949, membro di redazione di Neue Wege.
(fonte: Die Bauern wollten nicht den Krieg, Neue Wege - trad.: G. M. Schmitt)